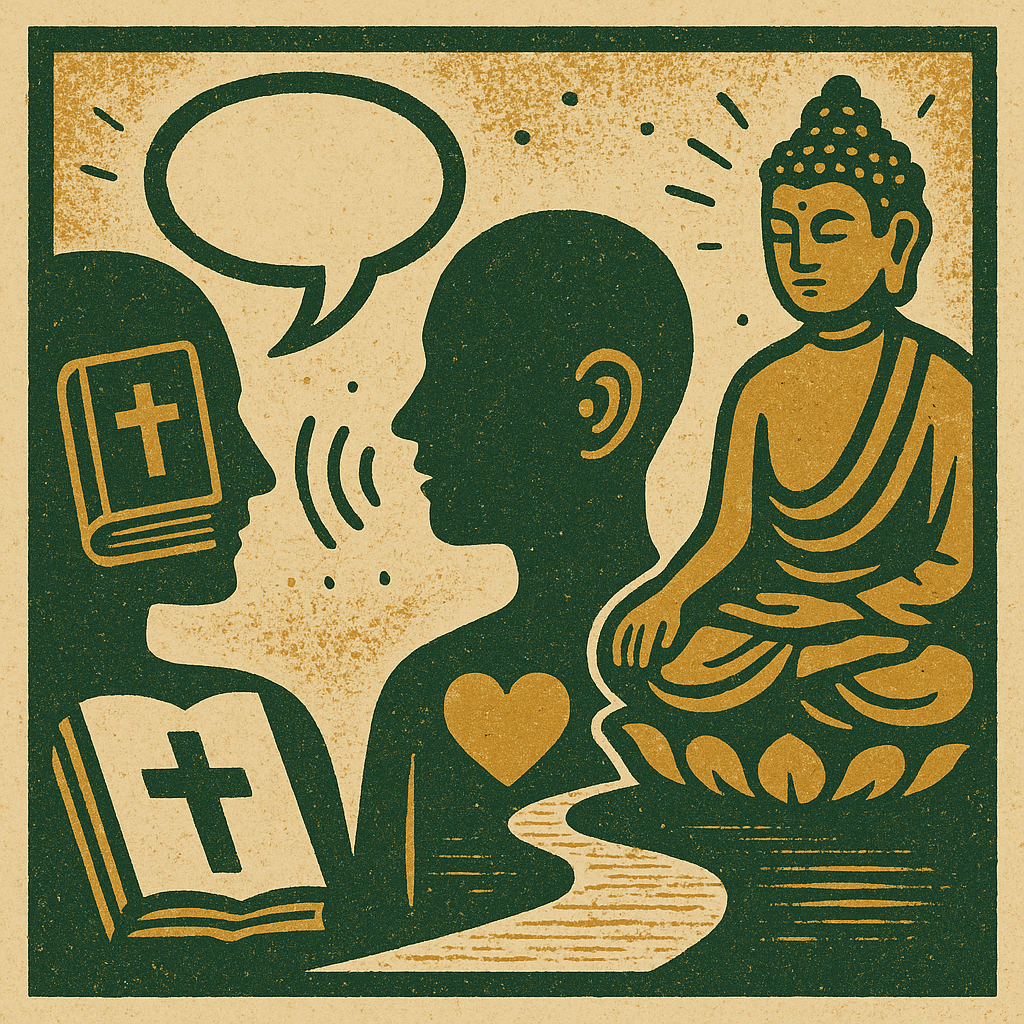Sai, con questa rubrica sulla Bibbia sto attirando più antipatie che simpatie. Mi dici che era prevedibile? Mah, a dirla tutta, forse i social non sono nemmeno il posto giusto per fare riflessioni del genere. Però, oh, si tratta solo di post in cui io parto dalla Bibbia, certo, ma ci ragiono su con quel modo mio, personale, artigianale, incerto, di ragionare su simboli e storia. Non lo faccio per catechizzare nessuno, figurati. Lo faccio per riflettere “ad alta voce”, per mettervi a parte di ciò che a oggi mi pare di aver capito su alcune cose. E per attraversare, questo sì, col mio passo zoppo, un testo che è stato attraversato da milioni di altri passi, spesso più sicuri ma non per questo, in linea di principio, più veri.
I ragionamenti che porto qui sono dunque miei, credo che ormai tu lo abbia capito. Sono riflessioni che partono magari da una parola, da un verso, da un’immagine della Bibbia (o dalla lettura che di quella parola, verso o immagine han fatto la tradizione o qualche pensatore famoso), ma alla fine, probabilmente, dicono più di quello che penso io della vita che non di quello che dice la Bibbia. Chi lo sa.
Forse è proprio questo che ha fatto incazzare un po’ di gente: da una parte i sedicenti atei, che non riescono a sentire nominare la Bibbia senza pensare a un vecchio con la barba che minaccia l’inferno; dall’altra i sedicenti cattolici, che appena sentono qualcuno nominare la Bibbia fuori dal loro perimetro dottrinale si affrettano a fare la guardia al tempio. Almeno su una cosa, però, questi due gruppi si trovano d’accordo: che sto sbagliando. Eppure, nessuno di loro, il più delle volte, viene qui per argomentare.
Perché sì, parlo di Bibbia. Ma come ho detto poi ci metto dentro tutto quello che ho: tutto quello che ho letto, vissuto, pensato, capito e frainteso. Non ti offro verità indiscutibili, da difendere a spada tratta. Tutt’altro. Offro pezzi di cammino, stralci della mia ricerca personale. Verità – se così vogliamo chiamarle – che per me, e per chi ha orecchie simili alle mie, sono e restano comunque un “work in progress”. D’altronde, la Verità è o non è un processo storico, come diceva Hegel? Una faccenda aperta, dico, che non si può mai dire conclusa.
Quindi non vengo a dirti “seguimi che ti guido” (per carità divina!), al massimo ti dico: “io sono arrivato fin qui, se vuoi facciamo un pezzo di strada insieme”. E se qualcuno si urta per le mie parole, pazienza: le mie elucubrazioni non vengono dalla cima di una cattedra, ma dal tavolino dove mi metto, la mattina, a carburare prima di andare al lavoro; dall’angolo del bar sotto casa mia (davanti a un ottimo cappuccino delattosato e decaffeinato, per amor di completezza) che da qualche tempo è diventato il mio secondo ufficietto.
E comunque, oh: io non sono nessuno. Atei, cattolici, che vi mettete a fare a darmi importanza? Non me la merito. Non sono un esegeta, non sono un teologo, non sono un esperto di greco, ebraico o aramaico antico. Sono solo un cercatore. Come tanti altri (come lo siete voi!). Sono solo uno dei tanti che espone sé stesso sui social. Lui mette i selfie, lei mette le paste al forno, io metto i selfie, le paste al forno e ogni tanto i miei pensieri.
A ogni modo, la mia unica vera convinzione è che per capire qualcosa bisogna farla passare attraverso di sé. Verbalizzarla, farla filtrare dalla carne, offrirla agli altri come si offre un pane spezzato (che prima del vangelo – così mi han detto – era una pratica rituale e usuale in tutte le famiglie, prima di cominciare a mangiare). Esporsi. E accettare che non tutti mangeranno con te. Anzi, molti ti rideranno in faccia.
Tra l’altro, “pubblicare” i propri pensieri è un modo potentissimo per mettere alla prova i pensieri stessi e le proprie convinzioni: se sopravvivono all’esposizione sociale… chissà, forse vuol dire che qualcosa di buono dentro ce l’hanno. Ma se un po’ di antipatia social riuscisse a fermarmi…
Detto questo, se proprio potessi scegliere da chi farmi contestare, mi piacerebbe che fosse qualcuno che la Bibbia l’ha almeno letta. Che ci ha perso del tempo. Che ha trovato una frase che lo ha consolato. Che si è arrabbiato, che ha pianto, che ha riso. Che ha sentito risuonare dentro una parola antica come una corda che vibra ancora, sia nel bene che nel male. Che, se la trova vecchia e pericolosa, sappia almeno per quale motivo lo pensa; che conosca la sua storia, che abbia chiesto in giro, che si sia domandato com’è che, ancora oggi, delle persone apparentemente sane di mente si mettano a leggerla e la trovino piacevolmente ispirante.
Invece la maggior parte delle critiche mi arriva da chi non sa nemmeno quanti figli hanno avuto Adamo ed Eva. E già questo mi dà delle cose su cui riflettere. Perché stiamo parlando di pagina 1, eh.
C’era una battuta, se non sbaglio di un altro esegeta amatoriale, che diceva del Cattolicesimo:
“La religione fondata su un libro che la maggior parte dei suoi fedeli non ha mai letto”.
Ed è vero. Facciamo la prova? Poni a te stesso o a un cattolico questa domanda: “Quanti figli hanno avuto Adamo ed Eva?”. C’è chi ti dice due. Caino e Abele. Se va bene. Altri ti dicono “boh”.
(E comunque erano molto più di due, altrimenti, in accordo con il mito, come lo popolavano il mondo?!).
E allora ti viene da pensare che prima di parlarne, forse, bisognerebbe leggerla, la Bibbia. Anche solo per sapere cosa ti dà fastidio davvero. Perché se ti senti offeso da quello che dico, potrebbe essere che sto toccando qualcosa in cui credi. O qualcosa in cui dici di non credere, ma che in fondo – è quello che sembra – ti muove lo stesso.
Ché, poi, non dovrebbe essere così con tutte le cose? Se pensi che Mussolini sia il male, vuoi comunque prima leggerla qualcosa su di lui? Altrimenti il primo fascista viene e ti asfalta a colpi di citazioni ed esempi (magari anche inventati, ma non lo sapresti) a cui non potrai controbattere.
Ce l’hai con i cospirazionisti, credi che siano degli idioti patentati? Bene, per quale motivo? Ah, sì, perché credono che la terra sia piatta mentre tu SAI che la terra è tonda. Poi viene il complottista e ti dice: spiegami come lo sai. E scopri che non è che lo sai davvero, perché se lo sapessi davvero sapresti anche dimostrarlo, in qualche modo, che è tonda. Ti limiti invece a dire: perché sì, perché lo sappiamo da secoli, perché la tecnologia, le foto, i video, la Nasa… Ok, anche qui, il complottista verrà e ti asfalterà. Perché lui avrà letto e studiato – MALE, ok – la sua posizione, e nel peggiore dei casi saprà ripetere a pappardella le versioni di chi, nel tempo, ha foraggiato le sue teorie. Mentre tu, semplicemente, ti sei semplicemente “fidato” di qualcuno che, a senso, hai ritenuto autorevole. Hai “creduto”, insomma.
Tu tornerai comunque a casa convinto dei ca**i tuoi, però dentro c’avrai una rabbia… “Sto cretino”, ti ripeterai, “voleva davvero convincermi!”. E però il cretino è fuori che si diverte e tu stai ancora pensando a lui, rodendoti il fegato.
In questo senso, anche l’ateismo cieco è una forma di fede. Se ti opponi alla Bibbia con la spada tratta e non l’hai mai letta, sei esattamente come chi la difende a oltranza senza averla mai letta o capita. In entrambi i casi c’è una pretesa di sapere senza aver attraversato. E non la chiamerei nemmeno ideologia, perché l’ideologia, almeno secondo me, un minimo sindacale di consapevolezza, a volte, te la concede. Qui invece c’è solo tifo, c’è – è la mia opinione, va bene – un po’ di paura: quella che “se crolla una nostra certezza muore una parte di noi”.
E infine ci sono quelli che mi dicono: “Eh, ma tu ci credi? E allora sei un predicatore”. E altri che mi accusano del contrario: “Eh, ma tu non ci credi davvero, tu inventi, dici troppe cose strane”. Per ultimi, ci sono quelli che urlano all’ipocrisia: “Predichi bene e razzoli male, cambi continuamente opinione”. Una mi ha detto: “Ti conosco da una vita, dieci anni fa non avresti mai scritto certe cose e secondo me tra dieci anni cambierai di nuovo opinione”.
E grazie al ca…
Grazie al cielo, cioè, e letteralmente: “sono vasto, contengo moltitudini: certo che mi contraddico!”. L’ha detto Walt Whitman, questo, non io.
E così, oggi, volevo parlare un attimo del buddismo. Perché anche lì, in quell’altra storia sacra, si dice qualcosa che forse potrebbe aiutare a capire meglio non solo il modo in cui leggo la Bibbia io, ma anche il modo in cui molte persone reagiscono, troppo in fretta, a chiunque osi toccare certi temi fuori dai binari.
Il buddismo, come lo conosciamo in occidente, ci sembra avere una strana umiltà di fondo: non ti dice cosa pensare – come sembrano invece fare le religioni organizzate – ma come guardare. E la prima cosa che ti insegna è che non puoi vedere chiaramente se sei troppo attaccato a ciò che credi già di sapere. Se sei attaccato all’idea di avere ragione. Se reagisci invece di ascoltare.
In sanscrito si chiama avidyā: ignoranza. Ma non è un’ignoranza da scuola, non è che ti mancano delle informazioni: ti manca la vista. Sei come uno che crede di conoscere un luogo solo perché ne ha visto la mappa (o perché lo ha visto in televisione). E allora tutto ciò che non rientra in quella mappa lo rifiuti, lo combatti, lo prendi come un attacco.
Buddha dice, nel Mahānidāna Sutta, che
“È attraverso l’ignoranza che sorgono tutte le formazioni mentali. Con la cessazione dell’ignoranza, cessano anche le formazioni mentali.”
(Buddha, Mahānidāna Sutta – DN 15)
Ecco, quelle “formazioni mentali” sono anche i pregiudizi, i riflessi automatici, le etichette appiccicate sulle cose prima ancora di averle toccate davvero. Quando dici “questo è eresia”, “questo è fanatismo”, “questo è ridicolo”, ma non ti sei mai fermato ad ascoltare il cuore da cui quelle parole sono venute, stai solo reagendo da dentro una forma mentale. Magari non tua. Magari assorbita chissà dove. Magari ereditata, mai verificata.
E infatti Buddha lo dice chiaro – e lo dice in un sutta fondamentale, il Kalama Sutta – che non bisogna credere a nulla solo perché lo si è sentito dire, o perché lo dicono in tanti, o perché lo dicono i libri sacri.
“Non credere a nulla solo perché lo hai sentito. Non credere a nulla solo perché è detto da molti. Non credere a nulla solo perché è scritto nei tuoi libri religiosi. […] Ma dopo osservazione e analisi, quando trovi che qualcosa è in accordo con la ragione e conduce al bene e al beneficio di tutti, allora accettalo e vivi secondo esso.”
(Buddha, Kalama Sutta – AN 3.65)
È uno dei passi più profondamente liberi della storia del pensiero umano. E viene da un testo sacro. Ma, guarda caso, pochi lo citano. Perché anche nel buddismo, come ovunque, c’è chi preferisce la bandiera alla via.
E quando ci si aggrappa a una bandiera, succede questo: si giudica. Si aggredisce. Ci si contrappone. E Buddha, anche questo lo dice, lo conosce bene questo meccanismo:
“Le persone intrappolate nelle loro opinioni si scambiano parole taglienti, discutono, e poi combattono tra loro”
(Sutta Nipāta, v. 836).
Potremmo trascriverlo su un muro di Facebook e funzionerebbe come descrizione esatta del 90% dei commenti a ogni post che prova a dire la propria. Come se fosse impossibile distinguere tra un attacco e un’invocazione. Come se le parole “Bibbia”, “Cristo”, “Dio”, fossero una specie di scintille che fanno esplodere il nervo scoperto di chi non ha mai guardato a fondo dentro di sé.
E allora ecco che a me, che ci provo – con tutti i miei limiti – a cercare un senso, arriva l’accusa: “Ah, allora credi. Quindi stai predicando”. Oppure: “Ah, ma allora non credi abbastanza. Non puoi decidere tu cosa salvare e cosa no della Bibbia!”.
(Ché, tra l’altro, come ho scritto qualche giorno fa, io salverei tutto della Bibbia, semplicemente contestualizzandolo).
Ma io non sono un prete. Né un apostata. Non sono bastone né bandiera. Sono ANCHE tutte queste cose, forse, e nessuna di esse completamente. D’altronde, come ho detto: sono vasto, posso essere qualsiasi cosa.
Nel buddismo, a proposito di vastità, c’è un’altra immagine che amo moltissimo. È nel Udāna 5.5, quando il Buddha dice:
“Come il vasto oceano ha un solo sapore – quello del sale – così il mio insegnamento ha un solo sapore: quello della liberazione.”
(Buddha, Udāna 5.5)
Non dice “ha il sapore del Paradiso”. Non dice “ha il sapore dell’ortodossia”. Dice: liberazione. Allora se io leggo la Bibbia – o un testo gnostico, o un vangelo apocrifo, o un sutra zen – e in quel momento qualcosa in me si apre, qualcosa si scioglie, qualcosa si riconnette con la sorgente, quello è il sapore che conta. Il resto è rumore.
Ecco, quello che provo a fare in questa rubrica è cercare quel sapore lì. Non di dimostrare qualcosa. Non di convincere nessuno. Ma di condividere una via, una sete, un’eco. Non ho niente da insegnare. Ma forse qualcosa da raccontare sì. E se nel frattempo ti dà fastidio, ti urta, ti muove qualcosa… può darsi che non sia una brutta notizia.
Post-scriptum:
Ah. Dimenticavo.
Volevo tornare un attimo su quelli che dicono che “la Bibbia ha fatto solo danni”, che “i preti sono tutti pedofili”, che “il cristianesimo è una religione violenta, ed è cento volte meglio il Buddismo!”. E lo dicono convinti. Senza forse essersi mai seduti a leggere una paginetta del Vangelo o aver mai passato nemmeno un pomeriggio dentro un convento, in silenzio. Senza aver fatto un ritiro spirituale con dei frati trappisti o aver trascorso qualche giorno in un eremo buddista. Senza insomma aver visto niente, se non quello che già credevano di sapere.
È ovvio e umanamente comprensibile: in tv, per esempio, fanno più ascolti gli scandali dei preti pedofili che la storia di un frate missionario morto solo in un villaggio africano. E se parli bene della Bibbia, ti trattano come un ingenuo. Se ne parli male, sei nel partito giusto. Funziona così: lo sappiamo. Come al cinema, dove i film che fanno più soldi sono quelli più facili. Semplificazioni di pancia: da un lato “Prega Gesù e guarirai”, dall’altro “I preti sono tutti criminali”. La gente vuole semplificazione, e l’indignazione è un’emozione semplicissima da evocare. Ma la realtà – come sempre – è più complicata, più umana e più interessante.
Molti, poi, citano il Buddismo come “alternativa più pacifica”, “più laica”, “più intelligente” al Cristianesimo. Ma anche lì, se uno guarda davvero, scopre che non è tutto armonia e sorrisi. In Myanmar, per esempio, il buddismo non è stato affatto quella religione dolce, pacifica e nonviolenta che molti amano contrapporre al cristianesimo. A partire dal 2012 – ma le radici sono più antiche – alcuni monaci buddisti hanno giocato un ruolo attivo nella persecuzione della minoranza musulmana dei Rohingya, nello Stato di Rakhine. Ci sono stati interi villaggi bruciati, stupri di massa, esecuzioni. Decine di migliaia di persone uccise, centinaia di migliaia costrette a fuggire oltre il confine. E no, non parliamo solo di militari: a fomentare l’odio, a benedirlo pubblicamente, c’erano anche figure religiose, come Ashin Wirathu, soprannominato dalla stampa “il Bin Laden buddista”. Un monaco che parlava di pulizia etnica come se fosse un atto di fede. Per difendere “la purezza della nazione”, diceva.
Anche in Sri Lanka, nello stesso periodo, sono nati gruppi organizzati di monaci nazionalisti – come il Bodu Bala Sena – che hanno incitato alla violenza contro le minoranze musulmane e cristiane. Nel 2014, a seguito delle loro manifestazioni, ci sono stati scontri, incendi dolosi, negozi distrutti, morti. E anche lì, il messaggio era sempre lo stesso: “difendere la nostra religione”. Come se la religione fosse una fortezza da presidiare invece che una strada da camminare.
E anche nei testi sacri buddhisti, se li si legge senza filtri idealizzanti, si trovano versi spigolosi, selettivi, apparentemente contraddittori (versi insomma da contestualizzare al periodo storico in cui sono stati scritti). E allora, cosa facciamo? Buttiamo anche il buddismo nella spazzatura?
Questo non per dire che “tutte le religioni sono uguali” nel peggio. Ma per ricordare una cosa semplice: ogni forma spirituale può essere usata come identità e come arma. Anche quelle che sulla carta parlano solo di pace. La differenza non la fa il nome della religione, ma l’uso che se ne fa, e il modo in cui la si percepisce. Se diventa una bandiera, se diventa un confine, se diventa un modo per dire “noi contro loro”, allora anche la preghiera più pura può diventare miccia.
No. Quello che possiamo fare, invece, è accorgerci che ciò che emerge, nel discorso pubblico, non è mai tutto. È solo la parte che buca lo schermo, che fa scalpore, che conferma le paure o i pregiudizi. E non è colpa nostra se il nostro sguardo si ferma lì: è che il mondo che ci raccontano è costruito proprio per farci fermare lì.
In questa rubrica, poi, – lo dico chiaramente – non sto mica parlando della Chiesa. Né della Chiesa cattolica, né di un’altra chiesa. E nemmeno voglio parlare di “credere o non credere”. MI intesessa la Bibbia come testo. Un testo che, se vuoi, puoi anche non credergli e apprezzarlo lo stesso.
Ma se vuoi saperla tutta, persino nel Vangelo ci sono critiche alla Chiesa, critiche premonitorie, non molto differenti da quelle che ti senti di fare tu. Come nell’episodio dell’emorroissa (Mt 9,20-22): lei non si professa credente, non recita nessuna formula, non fa parte del gruppo. Ma si fa largo nella folla, allunga una mano e tocca il lembo del mantello. E Gesù si ferma. “Chi mi ha toccato?” chiede. E poi le dice: “La tua fede ti ha salvata.” Non “il tuo catechismo”, non “la tua ortodossia”. La tua fede. Che è desiderio, gesto, rischio, contatto.
E Gesù, in questo racconto, sente il suo tocco leggero e silenzioso della donna che lo ha capito – che nel suo messaggio ha creduto – pur sovrastato dal tramestio grossolano e superficiale della folla che ha intorno (una folla che è un gregge di pecore belanti, metafora – per molti esperti – della Chiesa fatta di persone, opulenta, a volte marcia dentro, mai sul pezzo, arretrata e sorda al vero messaggio evangelico). Fabio Rosini ha scritto un libro bellissimo partendo proprio da questo episodio. Se vi interessa, cercatelo. Si intitola “L’arte di guarire” e non è un libro per teologi. È un libro per chi cerca. Per chi si fa largo nella folla per toccare qualcosa che sente vero.
“Lo so, lo so”, sembra dire Gesù, la Chiesa che è sarà fondata in mio nome attirerà anche un mucchio di persone inconsapevoli e dannose per la Chiesa stessa, ma tu vieni comunque, perché anche in mezzo a quel casino mi vedrai e io ti vedrò
E allora, per concludere: questa rubrica non è un corso di religione, né un esercizio di devozione, né un tentativo di difesa. Non è nemmeno una provocazione. È un cammino a voce alta. È un modo per dire: io sto leggendo questo libro antico, e mentre lo leggo capisco delle cose. Non sempre sarà preciso, puntuale. Ma quando succederà, sento che valuterai la pena di fermarti a parlarne con me. Tutto qua.
Non sto cercando di convincere nessuno, amico mio. Sto cercando di ragionare a voce alta, come si dice. E se quello che leggi ti urta, ti emoziona, ti risveglia qualcosa – anche solo un pensiero che prima non c’era – allora forse ho fatto bene il mio lavoro. Anche se non ci credi.